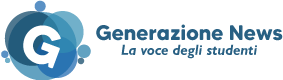di Anastasia Ghezzi
L’ opinione degli studenti e dei professori.
Di recente una professoressa ha acceso un dibattito sulle interrogazioni a scuola.
“Ma davvero oggi, nel 2025, siamo qui a fare interrogazioni come se fossimo nel 1890?” dice la docente, sollevando una critica alle interrogazioni tradizionali, evidenziando come possano essere un metodo obsoleto e inefficace per valutare gli studenti.
Il tempo impiegato per interrogare tutti, sottolinea, toglie spazio prezioso all’insegnamento e ai momenti per riflettere insieme, discutere, confrontarsi sul lavoro che si fa, sulle attività che mettiamo in campo per attivare processi cognitivi.
“Chi ha mai insegnato loro come si comunica bene un contenuto?” chiede l’insegnante “Pretendiamo che siano oratori, divulgatori, esperti retorici… ma nel programma, dove sta la voce educazione all’esposizione orale? Con quali strumenti li alleniamo a parlare davanti a un gruppo, a gestire l’emozione, a strutturare un discorso efficace, a orientare una narrazione?”
Secondo la docente “l’interrogazione è una pratica che evoca atmosfere poliziesche e porta i ragazzi a manifestare sempre più spesso ansia, blocchi, senso di inadeguatezza, paura. Così la docente si propone di superare la logica dell’interrogazione a tappeto, suggerendo strumenti di valutazione più inclusivi ed efficaci.
Ma le interrogazioni vengono viste veramente così dai docenti e dagli studenti?
Per questo mi sono rivolta ad alcuni miei compagni e insegnanti per sentire la loro opinione.
Le interrogazioni
Molti professori sostengono che le interrogazioni siano un’esperienza performativa che serve allo studente sia sul piano dell’apprendimento che su quello formativo, ovviamente si potranno sempre migliorare.
Alcuni studenti sono d’accordo: per loro le interrogazioni sono uno strumento per prepararli ad un futuro colloquio lavorativo.
Per molti, durante l’esposizione orale ci deve essere anche quell’alone di ansia e di tensione, poiché è un’emozione costante alla quale siamo sottoposti tutti, studenti e non.
Altri invece vivono le interrogazioni come un’esperienza stressante, che non ha più senso: sostengono che durante le verifiche orali impara soltanto l’interessato, mentre gli altri stanno lì ad aspettare.
È vero inoltre che spesso le interrogazioni si concentrano sulla memorizzazione e sulla riproduzione dei contenuti, piuttosto che sulla comprensione e sull’applicazione critica delle conoscenze.
Un bravo docente però deve saper indagare oltre la ripetizione a memoria e si deve anche chiedere se i propri metodi di insegnamento sono efficaci per gli studenti.
Il ragionamento che viene fatto sulle ore è sensato: si perde molto tempo con le interrogazioni, per questo è necessario trovare una strategia migliore, talvolta anche con dei metodi innovativi. Molti studenti sono d’accordo.
Ovviamente la scuola non può prescindere dalle interrogazioni perché è l’elemento che in tutta la vita sarà presente per ognuno di noi.
La necessità dell’esposizione orale
Molti studenti hanno espresso la necessità di avere un’educazione all’esposizione orale. Nessuno insegna loro come studiare realmente o esporre un contenuto, eppure viene chiesto loro di farlo bene.
Molti docenti sostengono che è importante insegnare agli studenti come comunicare efficacemente i contenuti e come strutturare un discorso efficace, per questo ritengono che la pratica delle interrogazioni sia necessaria. Per molti a volte è necessario mettere da parte il programma per fare un lavoro di miglioramento della scrittura, dell’esposizione orale e dell’atteggiamento che si ha nei confronti delle interrogazioni, aiutando così gli studenti nella gestione delle emozioni e dell’ansia.
Lo studio a volte è possibile farlo in autonomia, l’esposizione orale invece deve essere fatta in un certo modo, per questo è importante che i docenti aiutino i propri alunni. Tralasciando il mondo del lavoro e dello studio, può succedre di dover sostenere un dibattito con una persona che si conosce su un argomento, ed è importante avere la padronanza linguistica che si acquisisce negli anni di studio.
E’ necessario capire le esigenze che ha ogni studente.
Se un docente fa il suo lavoro adeguatamente, educa i ragazzi all’esposizione orale e lo fa anche tramite la correzione di quella stessa esposizione orale. Ovviamente è un processo di raffinamento e di allenamento. Le interrogazioni ci saranno sempre nella vita.
L’ansia da interrogazione
Ma come sono viste veramente le interrogazioni? Quali sono le emozioni che noi studenti proviamo?
Molti si sentono in soggezione, si sentono sotto processo. Vedono le interrogazioni come una performance.
Altri sostengono che bisogna saper gestire le proprie emozioni quando si cresce, a volte è necessario superare l’ansia da prestazione o la paura di un voto insufficiente. La valutazione è una condizione imprescindibile all’essere umano, per questo è necessario aiutare gli studenti con la gestione delle proprie emozioni.
Secondo i docenti, invece, l’affermazione dell’insegnante è senza fondamenta. Lei sostiene che “i ragazzi sono sempre più ansiosi e stressati a causa delle interrogazioni tradizionali”, ma è davvero così?
“Non possiamo incolpare un metodo che è sempre stato presente nel sistema scolastico, piuttosto è il contrario. Per molti questi tentativi di mettere gli studenti in una campana di vetro e tentare di risparmiare loro ogni stress giudicato “non necessario” impedisce loro di imparare come gestire l’ansia”.
La scuola deve essere un posto sicuro, una palestra, dove noi studenti dobbiamo affrontare le nostre emozioni. Solo così si possono sviluppare gli strumenti per gestirle.
I nuovi metodi di valutazione
L’autrice dell’articolo propone dei nuovi strumenti per valutare gli studenti: per esempio rubriche di osservazione durante il lavoro di gruppo, autovalutazione e valutazione tra pari, simulazioni, progetti, presentazioni, test strutturati e semi-strutturati, portfolio digitali e cartacei, osservazione sistematica del processo, non solo del prodotto.
Queste metodologie possono aiutare a creare un ambiente di apprendimento più inclusivo e formativo, dove gli studenti possono sviluppare le loro abilità e conoscenze in modo più autonomo e consapevole. Alcune sono già usate, altre talvolta potrebbero risultare imparziali o controproducenti.
Per esempio, l’osservazione sistematica del processo, e non del prodotto, si fa già. Esiste la valutazione diffusa, la quale tiene conto del percorso dello studente. Con il peer-assessment invece la valutazione non sarà mai equa. Nel migliore dei casi gli studenti si vengono incontro per solidarietà studentesca e si mettono voti alti, nel caso peggiore c’è qualche studente che si “vendica” essendo particolarmente sgradevole o severo, e neanche questo va bene.
Secondo i ragazzi intervistati questi nuovi metodi risultano più semplici e utili. Gli studenti hanno proposto anche altri strumenti come i lavori di gruppo, le presentazioni, i progetti, magari anche usare la tecnologia attraverso podcast o video, oppure scrivere dei diari dove raccontiamo le cose capite, così che si possano sentire più coinvolti e stimolati.
Per molti studenti la valutazione è un’occasione per capire i propri punti forti e quelli da migliorare, la sua utilità viene meno quando risultano solo numeri, senza una crescita da parte di ognuno di noi, e questi metodi alternativi “sono risultati inefficienti, oltre che presi poco seriamente”.
Quindi cos’è meglio per noi ragazzi?
In un periodo storico in cui si cerca sempre di più la novità, l’alternativa rispetto al classico, è importante saper riconoscere in cosa veramente serve un cambio di regime e in cosa no.
Sicuramente si possono prendere in considerazione delle modalità alternative di valutazione. Tuttavia rimane il fatto che i ragazzi agli esami all’università e a lavoro avranno un colloquio da sostenere, avranno presentazioni da fare, saranno inevitabilmente sottoposti a giudizio nella loro vita, perché tutti noi lo siamo, nel mondo in cui viviamo così è.
Ma nonostante l’interrogazione non possa prescindere dall’istituzione scolastica, non può più essere tradizionale come ai vecchi tempi.
Non si può interrogare un ragazzo con tanta ansia, facendo finta che questa non ci sia, mettendo anche un voto negativo perché non ha saputo esporre. A quel punto diventa un fallimento degli insegnanti che non hanno cercato di farti capire come affrontare un colloquio orale.
Ad oggi è richiesta una proprietà linguistica di un certo livello e anche una tranquillità nel farlo. La scuola quindi deve essere una palestra. Questa categorizzazione “interrogazione si o interrogazione no” è troppo dura. La scuola, e di conseguenza gli insegnanti, devono dare gli strumenti, talvolta anche duri e dolorosi, per affrontare tutto ciò che c’è là fuori e che verrà dopo.
Considerare l’interrogazione un metodo antico non è giusto, perché capiterà sempre nella vita.
Magari incontriamo per caso un giornalista per strada e ci fa un’intervista e non sappiamo dire due parole per la tensione che ci blocca.
Ci vedono fragili come gioventù e credono che facendo così ci aiutano. Ma in realtà spengono la nostra forza e il nostro furore, ciò che arde dentro di noi a questa età. La scuola di oggi cerca di nasconderci sotto una campana di vetro, di distenderci sugli allori, per proteggerci.
Il docente e la scuola devono essere un passaggio, una palestra, per affrontare tutte le situazioni che verranno. Se sappiamo esporre, se sappiamo gestire le nostre emozione o quello che vogliamo dire, va tutto in discesa. Come si impara questa cosa? Per molti con la sana tensione, con la sana ansia delle interrogazioni. Ovviamente non deve essere troppa altrimenti ci blocca, però può essere uno strumento funzionale.
È tempo di rivedere le pratiche di valutazione e di adottare un approccio più olistico e formativo, che tenga conto delle diverse esigenze e abilità degli studenti, questo è certo. Solo così possiamo creare un ambiente di apprendimento più stimolante, dove gli studenti possano crescere e svilupparsi in modo più completo.
Non bisogna rincorrere le mode del momento, soprattutto quelle che tendono a semplificare le prestazioni di noi studenti oppure quelle che mirano a velocizzare la valutazione, perché se è vero che le competenze sono importanti, queste necessitano di poggiare sui contenuti. E i contenuti bisogna impararli!
Riempiendo la didattica di metodi innovativi non facciamo altro che svuotare l’insegnamento della sua funzione primaria: insegnare, fornire delle conoscenze e competenze.
L'autrice / autore
Non ho talenti speciali, sono solo “appassionatamente curiosa”, direbbe Einstein se fosse al mio posto.
Tra le colline della maremma grossetana, ho sempre trovato un rifugio nei libri. Le emozioni degli autori attraversano le loro penne, mi sento più vicina a loro ed è così che ho imparato a conoscere veramente il mondo.